In questo articolo i principali spunti emersi dal webinar “Gestire le differenze culturali in azienda” organizzato da Speexx. Un confronto tra esperti di formazione, risorse umane e sport su cosa significhi davvero esercitare una leadership interculturale oggi, tra stereotipi, ascolto e competenze chiave.
Immaginate di andare per lavoro in un Paese totalmente diverso dal vostro o di dover iniziare a interagire in un team in cui le persone appartengono a culture differenti, il tutto senza spostarvi dall’Italia.
Il primo modo per approcciarsi a mondi diversi è certamente quello di provare a parlare la stessa lingua di chi c’è dall’altra parte o utilizzarne una per convenzione – come l’inglese – che possa favorire la relazione.
Ma spesso la lingua non basta, quando si parla di interculturalità e di multiculturalità – e tra poco vedremo come non sono la stessa cosa – bisogna fare i conti con tanti altri aspetti. E soprattutto, se si guidano delle persone, bisogna cercare di avere una “leadership interculturale“.
Ma cosa significa e come favorire davvero l’interculturalità al lavoro?
Di questo tema si è occupata Speexx che, oltre al podcast UNIVERSI – Unici e Diversi, lanciato nel giugno 2025, ha organizzato il webinar dal titolo “Gestire le differenze culturali in azienda: strumenti e approcci per una leadership interculturale”.
Con la moderazione di Luca Maniscalco, responsabile marketing & comunicazione Fondazione UNIMI, si è parlato di interculturalità e leadership da prospettive complementari: quelle della ricerca accademica, dell’esperienza aziendale e ovviamente del vissuto personale.
Tra gli ospiti: Raffaella Temporiti, Chief People Officer di Max Mara, Barbara Quacquarelli, professoressa di organizzazione aziendale e direttrice della MIT Sloan Management Review Italia, e Diego Aldo Pettorossi, atleta olimpico e consulente.
In questo articolo cerchiamo di condividere alcuni concetti salienti emersi durante il dibattito, utili come memorandum per chi c’era e come spunto per chi non avesse potuto partecipare.
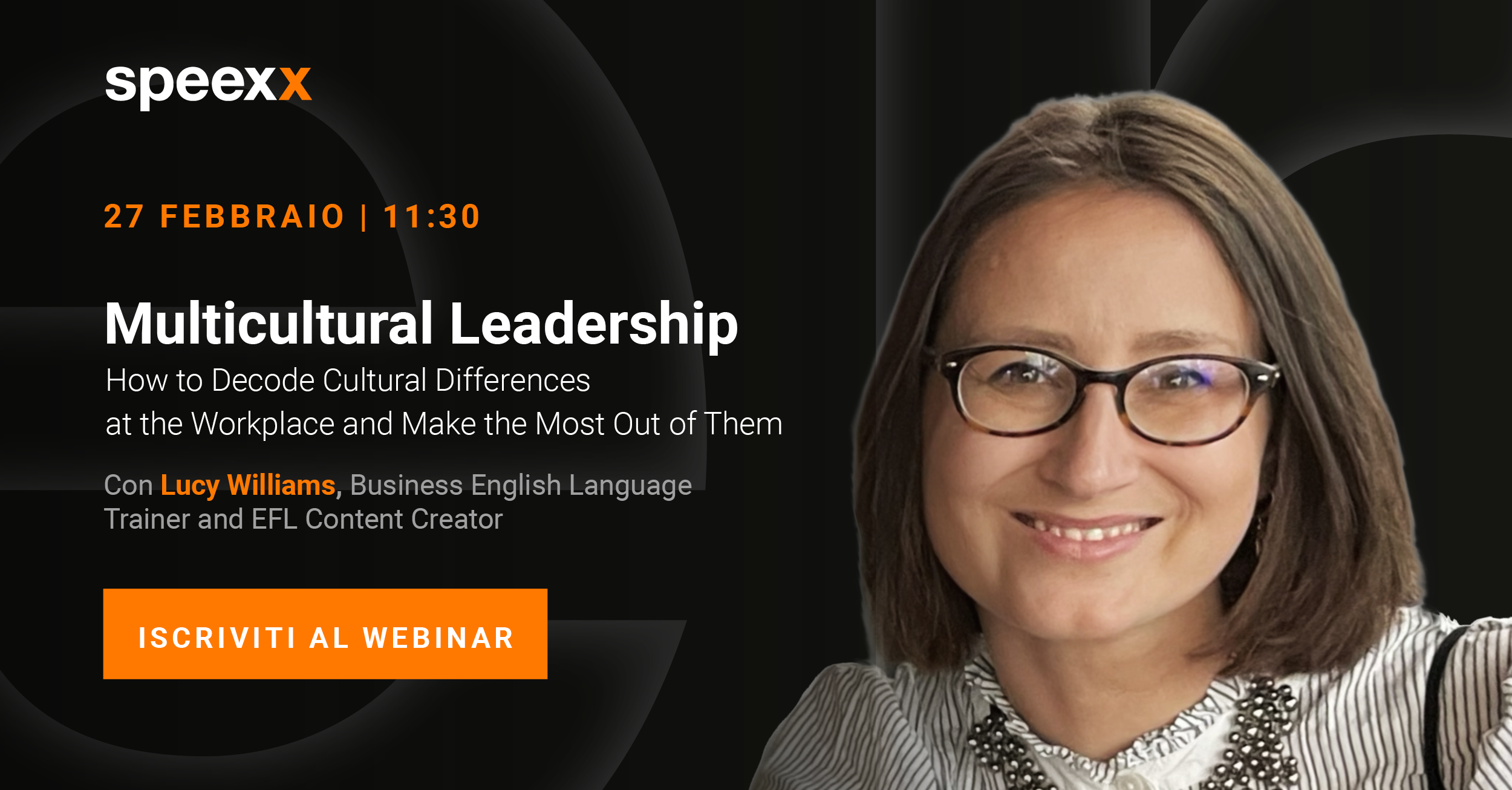
La leadership? Non è universale, ma risente molto dei contesti culturali
Avete mai pensato che il concetto di leadership universale non trova davvero corrispondenza nella realtà di tutti i giorni?
È infatti uno di quei miti da sfatare, come ha fatto notare in apertura di webinar Barbara Quacquarelli: “La leadership è una competenza che cambia radicalmente da una cultura all’altra. Negli ultimi decenni l’internazionalizzazione non ha più riguardato solo il mondo occidentale, ma si è estesa a contesti molto lontani da quello anglosassone, con presupposti culturali completamente diversi. Ciò ha messo in crisi l’idea di un modello di leadership “universale”.
Quacquarelli ha rafforzato il concetto con un esempio concreto: nel mondo possiamo individuare culture ad alta distanza di potere, in cui è atteso uno stile di leadership molto direttivo e culture che valorizzano uno stile partecipativo e orizzontale.
Nei primi contesti, il leader viene percepito come una figura forte, decisiva, con potere esplicito mentre, al contrario, in Paesi come quelli scandinavi, quello stesso stile direttivo viene vissuto come autoritario. Pertanto, la stessa persona, bravissima nel suo ruolo, può ottenere risultati completamente diversi semplicemente cambiando contesto culturale.
Gli esempi in tal senso si sprecano, ma la professoressa e direttrice di Sloan Academy, ne ha ricordato uno tra tutti. vissuto in prima persona quando nella sussidiaria di una multinazionale svedese, arrivò un nuovo amministratore delegato svedese.
“Forte degli stereotipi sull’Italia – paese caloroso e socievole – iniziò a fare molte domande e ad aspettarsi che i collaboratori andassero a parlargli spontaneamente. Ma nessuno lo faceva. Perché? Perché in Italia, dove l’aspettativa gerarchica è ancora forte, il capo è visto come colui che dà direttive. I collaboratori lo percepivano addirittura come una persona incerta, anziché apprezzare l’apertura ‘Fa troppe domande, forse non sa cosa deve fare’.
L’esempio dimostra come la leadership sia sì una strategia di influenza, ma la sua efficacia dipenda fortemente da come viene percepita in un dato contesto culturale.
Multiculturalità e interculturalità: le differenze
Multiculturalità e interculturalità non sono sinonimi, e la differenza ha un impatto reale sul lavoro quotidiano. A chiarire i due concetti, durante il webinar, è stata Raffaella Temporiti, Chief People Officer di MaxMara.
La multiculturalità, ha spiegato, è un approccio reattivo attraverso il quale, sostanzialmente ci si “limita” a gestire la diversità, quando si parla, invece, di interculturalità l’approccio è proattivo, basato su consapevolezza profonda delle differenze culturali, dei valori e degli stili di comunicazione.
Ecco perché: “essere un leader interculturale oggi è essenziale. Non basta conoscere le usanze di un Paese, serve sviluppare una comprensione autentica delle prospettive diverse, anche considerando l’impatto di fattori esterni come il contesto geopolitico. che ha un impatto anche dentro le aziende. Comprendere che certe dinamiche toccano emotivamente colleghi e collaboratori è parte della responsabilità di leadership”.
Le squadre multiculturali, se ben gestite, d’altra parte, sono un vero vantaggio competitivo. Ma attenzione: “Conoscere le differenze è solo il primo passo, il vero salto arriva con l’inclusione delle diversità, che non avviene spontaneamente, ma, piuttosto, va progettata, costruita, allenata”.
E cosa significa fare inclusione delle diversità? Secondo Temporiti vuol dire basarsi su:
- ascolto attivo
- empatia
- valorizzazione delle relazioni
- costruzione di un clima di fiducia, che è ciò che apre le porte all’innovazione
“Per far sì che tutto questo avvenga servono una strategia di comunicazione adattabile e una leadership vulnerabile, in grado di riconoscere gli errori e ricalibrare le scelte. Io”, ha ammesso l’HR – “l’ho imparato sul campo, in anni di lavoro all’estero: non si sa mai tutto, quindi è necessaria formazione continua e una disponibilità a mettersi in discussione costante”.
Altrettanto importante è non focalizzarsi solo sulle differenze, ma “bisogna cercare i punti in comune: è solo così che si costruiscono ponti”.

Cosa succede quando la cultura che conosci si incontra – o si scontra – con quella di qualcun altro?
Che forma prende il lavoro quando ogni giornata è un intreccio di culture, abitudini e visioni del mondo diverse?
Questo è UNIVERSI, il video podcast che dà voce a chi sperimenta ogni giorno la multiculturalità sul lavoro.
Un progetto di Speexx, in collaborazione con SenzaFiltro, pensato per esplorare – con occhi aperti e orecchie attente – cosa significa davvero lavorare, comunicare e crescere in ambienti professionali internazionali.
L’adattamento culturale nello sport e nella vita
Diego Aldo Pettorossi ha portato una prospettiva umana e personale sul tema. Atleta olimpico e data scientist in Deloitte, ha raccontato le sue esperienze di adattamento nei contesti sportivi internazionali e nel mondo del lavoro. “Negli Stati Uniti ho imparato a riconoscere le differenze, a mantenermi fedele alla mia identità senza chiudermi all’integrazione. Serve equilibrio tra appartenenza e adattamento”.
Il suo racconto ha aggiunto una dimensione concreta al concetto di leadership interculturale: è un allenamento continuo alla flessibilità e alla consapevolezza. “Anche io ho vissuto contesti che mi hanno costretto ad adattarmi, spesso velocemente”, ha spiegato. “Ciò non significa diventare ‘camaleontici: io non cerco di diventare un americano medio quando sono negli Stati Uniti o un italiano stereotipato quando torno a casa. Per me, adattarsi significa rispettare il contesto senza annullare sé stessi”.
Pettirossi ha poi portato l’interculturalità nel mondo olimpico nel quale uno dei gesti più semplici ma potenti è scambiare spillette con atleti di tutto il mondo. “Un gesto apparentemente banale, ma che mi ha permesso di avvicinarmi a culture diversissime. Non era solo un “Ciao, vuoi scambiare una spilletta?”, ma bisognava capire come approcciare l’altro, anche solo per rompere il ghiaccio nel modo giusto”.
Anche la mensa olimpica è un esempio: grandi tavoli condivisi, zero tavoli singoli: “Si vedeva chiaramente come ogni nazionalità affrontasse il momento del pasto in modo diverso. Gli americani tendevano a mangiare isolati, gli italiani in gruppo. E lì mi chiedevo: dove mi siedo? A volte bastava sbagliare posto per sentirsi fuori luogo”.
Oltre i luoghi comuni: se la Piramide di Maslow non è adatta a tutti
In qualità di ricercatrice, Barbara Quacquarelli ha poi evidenziato come a non favorire l’interculturalità ci siano varie affermazioni, diffuse in particolare sui social e legate alla leadership e alla motivazione che, pur essendo convincenti o “di buon senso”, spesso non hanno alcun fondamento scientifico.
Anche alcune teorie vanno in questa direzione, tra tutte la famosa piramide dei bisogni di Maslow.
“Nata negli anni ’50 e in un contesto anglosassone è priva di validazione empirica. Non esiste, infatti, una sequenza rigida di bisogni valida ovunque: in Paesi con alta avversione all’incertezza, come l’Italia o il Giappone, i bisogni di sicurezza hanno un peso maggiore rispetto ad altri contesti, e non è vero che non si possa motivare qualcuno all’autorealizzazione se prima non ha soddisfatto i bisogni di base. Maslow resta una tappa della storia degli studi motivazionali, ma non spiega più la realtà del lavoro contemporaneo”.
Un altro luogo comune è che “le persone lasciano i manager, non le aziende”.
“In realtà, le ragioni per cui si cambia lavoro sono molteplici”, precisa la ricercatrice, “e spesso legate a fattori come mancanza di opportunità di crescita, mismatch culturale, burnout o nuove opportunità.
Ridurre tutto alla figura del manager è una scorciatoia narrativa che ignora la complessità delle organizzazioni. Lo stesso vale per l’idea che un alto livello di engagement corrisponda automaticamente a una maggiore produttività: l’engagement è importante, ma da solo non basta se mancano competenze, risorse o obiettivi chiari”.
La leadership, soprattutto in contesti interculturali, non può essere gestita con “ricette veloci” o modelli standardizzati. Serve studio, consapevolezza e la capacità di leggere contesti diversi con strumenti critici.
Perché costruire una leadership interculturale?
Il webinar si è chiuso con un messaggio condiviso: la leadership interculturale non è un traguardo, ma un processo. È fatta di consapevolezza, ascolto, errori e apprendimento. “Non si improvvisa”, ha ribadito Temporiti. Le organizzazioni che vogliono prosperare in un mondo complesso devono investire in percorsi formativi, mentoring e modelli inclusivi.
Come ha sottolineato Maniscalco: “Quelle che una volta chiamavamo competenze soft sono oggi competenze chiave per accompagnare e guidare il cambiamento”.

